

|
Come Studiare:Una Breve GuidaSuggerimenti e indicazioni che potrebbero aiutarvi nel completare proficuamente i vostri studi |
Traduzione della versione originale "How to Study" di William J. Rapaport, Department of Computer Science and Engineering, Department of Philosophy, and Center for Cognitive Science della State University of New York at Buffalo.
Ultimo aggiornamento: 19 Settembre 2011Nota del traduttore (A. Formisano): in questa versione italiana si è cercato di restate il più possibile aderenti alla versione originale. Sono state apportate solamente alcune modifiche marginali per meglio adeguare i contenuti al contesto del sistema scolastico/universitario italiano.
Se state leggendo una versione cartacea, potreste essere interessati a consultarne la versione online italiana o l'originale in inglese ove potrete trovare numerosi riferimenti a ulteriore materiale di approfondimento.


Molti sono dell'opinione che ogni persona abbia un differente stile di apprendimento (learning style). (Se concordi con questa opinione potresti trovare interessanti alcuni di questi riferimenti: Claxton & Murrell 1987, "Learning Styles" (Wikipedia), Keirsey Temperament and Character Web Site, William Perry's Scheme of Intellectual and Ethical Development, Holland 1966, Kolb 1984, Sternberg 1999. Per alcuni strumenti online, orientati a differenti stili di apprendimento, vedi "100 Helpful Web Tools for Every Kind of Learner".)
Nota comunque che non ci sono prove scientifiche a supporto del loro impiego! Il maggior studio in questo contesto è Pashler et al. 2009. Vedi anche Glenn 2009/2010.
Quindi, ogni persona ha un differente modo di studiare. Tuttavia, il modo di studiare che stai attualmente adottando potrebbe non essere il migliore per te. Come lo puoi verificare? Facile: se i tuoi voti non sono quelli che vorresti, allora, probabilmente, devi modificare il modo in cui studi!
In quanto segue ti darò dei suggerimenti su come studiare efficacemente. Questi consigli hanno funzionato nel mio caso, quando frequentavo la high school, il college, e la graduate school. Inoltre, questi consigli si sono rivelati per me ugualmente utili in corsi umanistici (come filosofia e letteratura) e in corsi scientifici (come matematica e informatica). Siccome ogni persona ha un proprio modo di studiare, alcuni dei miei consigli potrebbero non essere adatti a te, se non con qualche aggiustamento personale. Nonostante ciò ti sprono a provarli. Molti studenti adottano con successo questi suggerimenti (eventualmente applicando qualche personale variazione).
Sentiti libero di indicarmi i tuoi suggerimenti per lo studio, quelli che hanno funzionato nel tuo caso. Cercherò di inserirli in future versioni di questa guida.
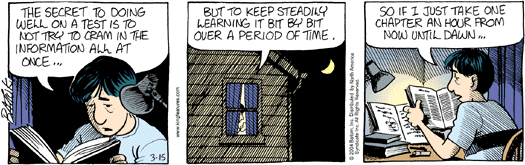
Studiare all'università è un lavoro a tempo pieno. Gestire bene il proprio tempo è importante.

Quanto tempo dovresti dedicare allo studio? Un recente saggio apparso in Chronicle of Higher Education rivelerebbe che gli studenti non studiano abbastanza. Ma, quant'è abbastanza? Assumendo che la tua educazione sia un impegno a tempo pieno, dovresti dedicarvi attorno alle 40 ore settimanali. Considera una situazione tipica nel sistema accademico italiano, dove ad ogni credito corrisponde un totale di 25 ore di attività e un corso da 6 CFU prevede 42 ore di lezione. Allora ad ogni ora di lezione in aula devono corrispondere circa 2 ore e mezza di studio autonomo. Se stai seguendo, diciamo, tre di questi corsi che prevedono globalmente 12 ore di lezione in aula, allora dovrai completare lo studio settimanale con circa 30 ore di lavoro a casa (o in biblioteca, o...).
Ovviamente dovrai distribuire questo lavoro lungo tutta la settimana. Per fare un esempio, supponiamo che tu decida di studiare solo la sera, tutti i giorni dal lunedì al sabato, lasciandoti libere le domeniche. Allora, suddividendo le 30 ore di lavoro a casa nei 6 giorni, dovresti studiare almeno 5 ore ogni sera. Se pensi che sia troppo allora dovresti considerare la possibilità di studiare anche in alcuni dei pomeriggi, o tardi la notte, o sacrificare qualche domenica.
Ovviamente questo è un esempio. Se stai seguendo un singolo corso da 2 ore di lezione alla settimana, allora dovresti aggiungere solo 5 ore di lavoro a casa.
Se svolgi qualche lavoretto sporadico per guadagnare un po' di soldi, dovresti farlo sottraendo tempo al tuo tempo libero, non riducendo il tempo dedicato allo studio! (Altrimenti dovresti considerare la possibilità di rinunciare a qualche lavoretto o ridurre il numero dei corsi che stai seguendo).
Se ti sembra troppo, considera che i corsi universitari sono diversi dai corsi delle superiori, che probabilmente ti sono più familiari. I corsi universitari hanno un carattere più intensivo, comprendono meno ore di lezione in aula e richiedono una maggiore mole di lavoro svolto indipendentemente/autonomamente dallo studente per approfondire e acquisire le nozioni.
Poniti degli obiettivi graduali e scadenzati. Se non riesci a raggiungerli, allora riduci le attività non connesse allo studio. Se non puoi, perché devi lavorare per vivere, considera la possibilità di iscriverti all'università come studente lavoratore o part-time (ciò ti permetterà di diluire il tuo percorso formativo in un numero maggiore di anni).

Per alcuni suggerimenti su come gestire il tuo tempo nella preparazione degli esami vedi dopo.
Per alcuni suggerimenti su come gestire il tuo tempo nello svolgimento di progetti vedi dopo.
Per alcune risorse web sulla gestione del tempo, puoi dare una occhiata a questi siti:
È meglio concentrarsi sullo scrivere gli appunti o concentrarsi
sulla comprensione di ciò che si sta spiegando a lezione?
Paradossalmente, mi butterei più sullo scrivere appunti completi che sul
pretendere di capire perfettamente tutto e subito. La comprensione
approfondita verrà in un secondo tempo, quando
rivedrai i tuoi appunti.
Infatti se i tuoi appunti saranno incompleti allora sarà proprio difficile
comprendere ciò che non hai neanche scritto.
(Una tecnica simile si basa su un sistema per abbreviare chiamato Speedwriting.
Ecco un esempio in inglese:
Ovviamente, il punto focale nell'usare abbreviazioni è usare abbreviazioni che hanno senso per te.
Puoi inserire, a margine dei tuoi appunti,
una leggenda (come la tabella precedente) per le abbreviazioni che "ti inventi sul momento".
Tuttavia, se hai un dubbio o necessiti di un chiarimento su qualcosa che il docente ha detto o scritto
(per esempio perché inudibile o illeggibile) , chiedi!
Non avere timore di fare domande!
Sii certo che ci sarà almeno un altro studente in aula (spesso più di uno)
che ti sarà estremamente grato per aver chiesto più o meno la stessa domanda che, per imbarazzo,
lui non ha fatto. Probabilmente susciterai l'apprezzamento da parte di questo studente (e del docente!).
Ricorda che: "Chi fa una domanda è ignorante per un istante, chi non la fa rimane ignorante per sempre".
Gli appunti sono spesso incompleti o abbozzati. La sola rilettura non è produttiva.
Inoltre, trascorsi solo pochi giorni o mesi dopo che hai preso i tuoi appunti, questi saranno
molto probabilmente praticamente incomprensibili.
Se non operi subito e attivamente sugli appunti correrai il rischio di
avere del materiale male organizzato o incompleto su cui studiare.
Ciò che ti suggerisco è di studiare i tuoi appunti riscrivendoli.
Utilizza un quaderno diverso da quello utilizzato per prendere appunti in classe.
Per la versione permanente (riscritta) dei tuoi appunti è meglio usare
un quaderno rilegato o a spirale, da cui non si stacchino i fogli.
Dopo ogni lezione, prima possibile (preferibilmente
la sera stessa o il giorno successivo), riscrivi gli appunti nella loro versione
permanente nel quaderno.
L'idea alla base del riscrivere gli appunti grezzamente presi in aula
(oltre, ovviamente, il riorganizzarli in una forma più leggibile)
è che proprio l'azione di ricopiatura è uno dei metodi migliori
per studiarli.
Successivamente potrai studiare le lezioni su una versione "permanente" degli appunti,
ripuliti, più leggibili, organizzati e completi.
Troverai dei suggerimenti su come fare ciò più avanti.
Sfrutta questa opportunità per riempire le lacune mentre hai ancora freschi in mente
gli argomenti della lezione.
Potresti scoprire che hai dei semplici dubbi o delle domande,
o che c'è qualcosa che non hai ben capito
o non hai colto durante la lezione. In tal caso, meglio! Aggiungi una nota
ai tuoi appunti e fai la domanda durante la successiva lezione!
Usa questa opportunità per (ri-)organizzare logicamente e con coerenza
i tuoi appunti. Se ti sembra opportuno,
puoi strutturare il materiale introducendo un indice
gerarchico. Per far ciò non sei obbligato ad adottare
un approccio "ufficiale" o uno stile particolare (come ad esempio,
usare il formato
I.A.1.(a)(i) oppure delle regole banali come "introdurre almeno due
sotto-sezioni, e non una sola, nell'articolare una sezione", ecc).
Scegli tu la forma che più ti soddisfa, dopotutto
sono i tuoi appunti.
Personalmente, preferisco numerare i punti principali (separandoli
con una linea), usando una indentazione per i dettagli:
Peggio ancora!! potresti esser tentato di usare il computer durante la lezione
per navigare su rete, leggere l'email o chattare con gli amici.
Non farlo! (Per un dibattito su questo argomento vedi
Adams 2006.)
Per questi motivi spegni il computer durante le lezioni. E anche l'iPod.
E pure in cellulare. E ogni altra cosa che potrebbe distrarti.
Per altre motivazioni per far ciò, vedi:
Studia prima gli argomenti difficili.
Quando la sera (o il giorno) studi o fai esercizi a casa,
affronta prima gli argomenti che richiedono maggiore lucidità, attenzione ed energia.
Lascia quelli più semplici, o più coinvolgenti, per dopo.
Studia in un luogo silenzioso, con meno distrazioni possibile.
Non ascoltare musica o guardare la TV: è praticamente impossibile
fare contemporaneamente due cose se una di esse è studiare.
(Per convincersi del perché sia difficile—se non impossibile—
fare due cose assieme ("multitasking"),
vedi:
Se non rifletti su cosa stai leggendo, ti posso garantire che finirai per
distrarti, la tua mente divagherà, gli occhi finiranno per fissare il vuoto
e finirai per addormentarti—è una forma di auto-ipnosi.
Quindi devi leggere in modo attivo. Potremmo dire che devi convertire
il materiale inerte del testo sulla carta in materiale interattivo,
cosicché tu possa avere una "conversazione" con il testo, come se tu stessi
dialogando con l'autore.
Il primo passo per leggere attivamente è leggere l-e-n-t-a-m-e-n-t-e.
Questo è un algoritmo per leggere un testo, qualsiasi sia il soggetto, lentamente
e attivamente:
Dato che non ci sono altre frasi da leggere (perché il test booleano del
WHILE è falso), hai capito il testo!
Questo algoritmo ha tre principali vantaggi:
Ma, come fai a sapere se hai capito la frase che hai appena letto?
Facile: dopo ogni frase domandati "perché?" (Pressley & El-Dinary 1992).
Per altre indicazioni sulla lettura lenta, vedi:
Questa tecnica può anche presentare altri difetti:
Una tecnica leggermente meno disordinata ma ugualmente inutile consiste nell'utilizzare
penna o matita per sottolineare i passaggi importanti o interessanti.
Ti posso garantire che finirai facilmente per sottolineare ogni frase in ogni pagina,
e non avrai ottenuto il tuo scopo.
La tecnica che ti suggerisco è comunque soggetta allo stesso rischio, ma
presenta "incorporata" la soluzione per evitare il problema.
Così potrai ri-leggere il testo e evidenziare differenti
passaggi topici ogni volta.
Il trucco consiste nell'enfatizzare un passaggio
tracciando una linea verticale al suo margine.
Io preferisco usare il margine destro e tracciare una parentesi quadra: ].
Se vuoi evidenziare [l'esatto inizio e fine del passaggio,] puoi usare parentesi quadre
direttamente nel testo, come ho fatto nell'ultima frase, unitamente alla linea verticale
posta al margine destro della pagina.
Così facendo, anche se hai erroneamente evidenziato tutte le frasi del
testo, almeno non hai rovinato le pagine.
Inoltre, quando ri-leggerai il testo (nota che ho detto 'quando', non 'se' :-),
potrai usare una diversa tecnica per evidenziare (ed esempio, sottolineando)
quei passaggi ancora più importanti.
Talvolta io uso parentesi doppie per enfatizzare durante una seconda passata: ]]
a la sottolineatura per la terza. (Se proprio devi, puoi anche utilizzare evidenziatori gialli per
una quarta passata, per evidenziare le parti super-extra-ultra-importanti.)
Ora supponi che tra alcuni mesi (o anni) tu desideri ritrovare
in un testo i passaggi più interessanti relativi ad un concetto,
diciamo per esempio a "coscienza". Come potresti rintracciarli?
Si può, ovviamente, scorrere tutto il libro fino a trovarli,
ma ciò che preferisco fare
è stilare un indice delle annotazioni che via via
ho apposto al margine delle pagine.
Ad esempio, se c'è un indice analitico nel libro,
posso aggiungervi una voce (ad es., "Coscienza: 10, 20"),
oppure scrivere un mio indice in una pagina bianca in fondo al libro.
Queste note possono essere utilizzate successivamente se deciderai di
scrivere una relazione o un articolo in cui discuti il materiale del testo.
A questo scopo ti sarà anche utile numerare le tue note.
Personalmente trovo utile questo schema: numera le pagine del notes con
numeri romani
(I, II, ecc.), numera ogni passaggio ricopiato (o commento) con cifre (1, 2, ecc.),
e con lettere (a, b, ecc.) ogni tuo commento associato a passaggi ricopiati.
Potrai riferirti, in una nota a margine del libro,
ad un punto del tuo notes con un codice (come ad esempio XIV-7-b, ovvero,
commento b sul passaggio 7, commento scritto alla pagina XIV del notes). Vedi anche dopo.)
Chiaramente, anche per un testo non letterario può risultar utile una lettura
completa e veloce, così da avere una visione "a volo d'uccello" dell'intero testo,
magari apportando delle annotazioni ai punti più impegnativi.
Poi applicherai le tecniche di lettura lenta e attiva per lo studio del testo.
E cosa dire delle (eventuali) versioni filmate o dei video di un testo da studiare?
Possono essere utili, ma in generale non possono sostituire la lettura.
Un'eccezione potrebbe esser ammessa per i copioni, che sono scritti
"per esser visti" piuttosto che semplicemente letti.
Se decidi di guardare in aggiunta alla lettura, cosa fare prima?
Io preferisco prima guardare e poi leggere. Sono infatti stato spesso deluso
dal guardare un film dopo aver letto il testo da cui è stato tratto
(perché non corrispondeva all'immagine mentale che mi ero fatto durante la lettura),
invece non sono mai stato deluso dal leggere un testo dopo averne
visto l'adattamento cinematografico.
In aggiunta, guardare l'adattamento prima di leggere può aiutarti
nel visualizzare ciò che stai leggendo.
Non dovrebbe esserci bisogno di dire che devi fare i "compiti per casa" e devi farli
tempestivamente.
I docenti di corsi scientifici (ed anche altri, come quelli di lingua straniera)
assegnano spesso esercizi o problemi da svolgere come compiti per casa e, sovente, da riconsegnare.
Suggerisco fermamente di non svolgere velocemente i compiti e poi consegnare le
soluzioni. Piuttosto, svolgili in "brutta copia", controllali e poi ricopiali in bella copia e consegna questa (ricordando di metterci il tuo nome!).
Ancora meglio, puoi duplicare gli esercizi (e le tue soluzioni) ed inserirli nei tuoi appunti, prevenendo
l'eventualità che il docente li perda o non li restituisca in tempo utile da poterli
utilizzare quando studierai (questo accade, raramente, solitamente appena prima della
sessione d'esame, quando il docente ha molte cose da preparare).
Non scrivere semplicemente solo le risposte. Scrivi il problema e una soluzione
completa, che mostri come sei giunto alla risposta.
Per gli esami finali, cerca di dedicare più tempo possibile allo studio.
Non essere tentato, durante il tempo libero che hai in prossimità della settimana
degli esami, di fare qualcos'altro che non sia studiare.
(Se in un giorno vuoi prenderti del tempo per rilassarti, fallo
solo dopo aver completato lo studio previsto per la giornata.
Se devi sostenere
E esami e hai D giorni per studiare, dedica approssimativamente
D/E giorni ad ogni esame.
(Per esempio, se hai 4 esami e 5 giorni, trascorri un po' più di un giorno
(1.25 giorni per essere precisi) studiando per ciascun esame).
Se hai pochi giorni liberi allora pochi esami, se hai tanti giorni liberi allora
tanti esami, ecc., pianifica il tuo studio in modo da dedicare approssimativamente un tempo uguale per ogni esame e assicurandoti di dedicare allo studio l'intero giorno/notte che precede l'esame.
Per esempio supponi di disporre di 2 giorni liberi prima dell'esame #1, e un ulteriore
giorno prima degli esami #2 e #3.
Pensa ad ogni giorno come se avesse tre parti: mattino, pomeriggio e sera.
Assumiamo che ogni esame si svolga in una di queste tre parti (cioè non
occupi due parti consecutive della giornata).
Allora potresti dividere lo studio come illustrato nella tabella.
Considera che non dovresti ritardare lo studio per l'esame #3 fino a dopo sostenuto l'esame #2. Inizia a studiare subito per tutti gli esami.
Molti studenti non realizzano questo fatto perché hanno
un "illusione di competenza" (cioè, pensano di conoscere la materia meglio di
quanto effettivamente la conoscano) quando ri-leggono gli appunti e i libri
(Karpicke et al. 2009;
Belluck 2011), specialmente se ri-leggono passivamente invece che
attivamente.
Un metodo di studio migliore della ri-lettura passiva è il metodo "3R":
"rileggi-ripeti-ricontrolla", ovvero: "Leggi il testo, metti via il testo
e ripeti a voce alta tutto ciò che riesci a ricordare, quindi leggi
di nuovo il testo" (McDaniel et al. 2009).
Importante:
imparerai di più e ricorderai meglio svolgendo ripetuti test
(sia quiz in aula che esercizi a casa)
di quanto potrai fare con ripetute letture (Karpicke et al. 2009).
(Quindi quando il docente ti assegna molti quiz ed esercizi e ti richiede di
memorizzare fatti di base, non lamentarti! Questo è il modo migliore
di imparare e ricordare ciò che hai imparato.)
Le prossime sezioni ti forniranno alcuni suggerimenti su come fare tutto ciò.
Per le materie in cui devi risolvere dei problemi o scrivere delle dimostrazioni,
risolvi molti problemi tipici, presi dai libri di testo adottati dal corso o anche da altri testi
(ad esempio
le pubblicazioni Schaum's Outline Series
(McGraw-Hill)
sono di solito una buona fonte di questi problemi). Puoi anche chiedere al docente
di indicarti altre fonti di esercizi.
Come fare a sapere se le tue risposte sono corrette? Il modo migliore
consiste nel formare un gruppo di studio di due o più studenti: risolvete i problemi
e comparate le soluzioni. Se le risposte corrispondono, probabilmente sono corrette; altrimenti
potete recarvi dall'assistente del docente (se c'è) o dal docente.
Come per la fase della lettura lenta,
è sempre meglio chiedere aiuto al docente relativamente
ad un problema o una domanda precisa.
Memorizza le domande e le risposte—ma non
ripeterle semplicemente a memoria.
Scrivi per esteso le risposte:
copri la parte destra del foglio (la risposta) e
scrivi la risposta. Terminata una pagina, controlla
il tuo lavoro e eventualmente riscrivi le risposte alle domande a cui non hai dato risposta
(o ne hai data una errata) fino a quando rispondi correttamente a tutto.
Ricerche in psicologia suggeriscono che le persone imparano
più quando fanno errori di quando rispondono correttamente a tutto.
Quindi non avere timore di dare risposte errate!
(Vedi Roediger III, Henry L.; & Finn, Bridgid (2010),
"The Pluses of Getting It Wrong",
Scientific American Mind 21(1) (marzo/aprile): 39–41.
Perché scrivere e non semplicemente ripetere a voce?
Perché nel vero test d'esame dovrai scrivere le risposte.
Abituati a scriverle. (Ovviamente se dovrai affrontare un esame orale
ripetere potrebbe essere più appropriato che scrivere.
Tuttavia, uno tende a saltare i dettagli mentre ripete, specialmente
se si ripete a mente invece che a voce. Ma se scrivi le risposte
e hai buona memoria visiva, allora durante l'orale potrai "leggere" le
risposte nella tua mente).
Per un esame che prevede di risolvere degli esercizi o dimostrare dei teoremi,
affronta quelli più semplici per primi.
Quando hai finito rileggi accuratamente tutte le risposte.
E quando tutti gli esami sono finiti... attenti...:-)
Come stilare un indice?
I suggerimenti che seguono funzionano in quasi tutti i casi in cui
devi scrivere un indice.
Primo, scrivi una manciata di tematiche che vorresti discutere
(saranno le categorie in cui classificherai gli appunti),
descrivi ognuna di esse usando solo poche parole chiave. Decidi
in quale ordine vuoi scrivere delle varie tematiche e
quindi—su un foglio bianco—scrivi ogni argomento in testa ad una colonna.
Qualcosa tipo questo:
Queste saranno le sezioni principali della tua composizione. In aggiunta,
dovresti impostare sempre una sezione introduttiva e una conclusiva.
In ogni colonna scrivi le idee principali che vuoi includere nella corrispondente sezione.
Di nuovo, ordina queste idee usando solo alcune parole chiave. Queste saranno le tue sotto-sezioni.
Sotto ognuna di esse metti i numeri identificativi
dei passaggi dei tuoi appunti che vuoi includere nelle sotto-sezioni.
(Potresti scoprire che sarà necessario ripetere queste fasi
per impostare sotto-sotto-sezioni, ecc.
In tal caso compi questo passo quando sarai pronto per scrivere la sotto-sezione, non all'inizio.
Questo modo di procedere è detto "top-down design and stepwise refinement".)
Una volta che hai completato l'indice/traccia, inizia a scrivere, usando l'indice e gli appunti
come guida.
In questa fase non perdere troppo tempo a editare ciò che scrivi. Semplicemente scrivi! (Devo dire che alcuni preferiscono la
"scrittura libera",
in cui non si impiega del tempo preparando un indice.
Se questo è il tuo modo di procedere, fallo).
Ovviamente, dare un titolo a ogni sezione e sotto-sezione è sempre utile per tener traccia di dove sei, sia mentre scrivi che mentre leggi, come ho fatto io in questo documento.
E non procrastinare!
Per alcuni trucchi su come procrastinare il procrastinare, vedi:
D'altra parte, per argomentazioni a favore del procrastinare, vedi:
Abstract:
A questo punto probabilmente ti starai chiedendo
se devi realmente fare tutto questo.
Sembra un lavoro orribilmente enorme.
Beh! chiaramente non devi fare tutto in una sola volta.
Prova alcuni dei miei suggerimenti e verifica quali di essi funzionano per te.
Prova delle variazioni che possano meglio adattarsi al tuo stile di studio o alla
tua situazione personale. Tuttavia, in generale,
non esiste un modo veloce o facile per studiare.
Studiare è un lavoro duro e deve prendere molto tempo.
Quindi, devi proprio fare tutto ciò?
Sì (o qualcosa di molto simile a questo)—se vuoi realmente imparare
e ottenere buoni voti.
Infine, per ciò che può valere, ecco alcuni commenti da studenti e da altre persone che hanno
provato alcuni dei metodi descritti in questo documento. (Riporto i commenti in lingua originale.
Fanno riferimento alla versione in inglese.):
Goldbaum, Ellen (2009, December 17),
"UB Professor's Online Study Guide Makes a Great Gift That Keeps On
Giving",
University at Buffalo NewsCenter.
Adams, Dennis
(2006),
"Wireless Laptops in the Classroom (and the Sesame Street Syndrome)",
Communications of the ACM 49 (9 settembre 2006): 25-27.
Belluck, Pam
(2011),
"Take a Test to Really Learn, Research Suggests",
New York Times (21 gennaio 2011): A14.
Callender, Aimee A.; & McDaniel, Mark A. (2009), "The Limited
Benefits of Rereading Educational Texts", Contemporary Educational
Psychology 34: 30–41.
Claxton, Charles S., & Murrell, Patricia H. (1987),
Learning Styles:
Implications for Improving Educational Practices,
ASHE-ERIC Higher
Education Report No. 4 (Washington, DC:
Association for the Study of
Higher Education).
Glenn, David (8 gennaio 2010),
"Customized Teaching Fails a Test",
Chronicle of Higher Education:
A1, A7–A8.
Holland, John L. (1966), The Psychology of Vocational Choice
(Waltham, MA: Ginn & Co.)
Karpicke, Jeffrey D.; Butler, Andrew C.; & Roediger III, Henry L.
(2009), "Metacognitive Strategie in Student learning: Do Students
practise Retrieval When They Study on Their Own?", Memory 17(4):
471–479.
Kolb, David A.
(1984),
Experiential
Learning: Experience as the Source of Learning and Development
(Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall).
Pashler, Harold;
McDaniel, Mark;
Rohrer, Doug;
& Bjork, Robert
(2009),
"Learning Styles: Concepts and Evidence",
Psychological Science in the Public Interest 9(3): 105–119.
Sternberg, Robert J.
(1999),
Thinking Styles
(Cambridge, UK:
Cambridge University Press).
Swerdlow, Joel L. (agosto 1999),
"The Power
of Writing", National
Geographic 196(2): 110-133, 136.
3.1. Prendi appunti
Un buon studio fatto a casa inizia da buoni appunti presi a lezione.
Così come ognuno ha un diverso modo di apprendere, differenti docenti
hanno diversi modi di insegnare (che spesso non si accordano con
il modo di apprendere degli studenti!).
Alcuni docenti tengono lezioni poco interattive, altri tendono a incentivare la
partecipazione degli studenti, altri puntano sul lavoro individuale o sulla pratica in laboratorio,
ecc.
Conseguentemente, per seguire corsi diversi e lezioni di docenti diversi
potrebbe essere necessario prendere appunti in modi diversi.
I suggerimenti che seguono sono abbastanza generali da adattarsi a molte situazioni.
3.2. Prendi appunti completi
L'idea cruciale del prendere buoni appunti in classe è scrivere il più possibile.
Vi sono diversi motivi per prendere appunti nel modo più completo possibile:
3.3. Usa abbreviazioni
Prendere appunti completi richiede che tu scriva velocemente. Perciò conviene usare
delle abbreviazioni.
Qui di seguito ci sono alcuni esempi (alcuni copiati da altri studenti o docenti)
che dovrebbero darti una idea.
Se scrivi spesso SMS allora dovresti avere già familiarità con numerosi
modi di abbreviare le parole. Usali per scrivere gli appunti in classe!
ABBREVIAZIONE SIGNIFICATO
comp compilatore/compilare
cpt compresso/compatto
dim dimostrazione
exa esempio
exe esercizio
lang linguaggio
lex lezione
NB: nota/nota bene
oss osservazione
pma programma
prop proprietà/proposizione
prox prossimo
ptore programmatore
rel relazione/relazionale
sys sistema
s.t. tale che
→ implica, allora (simbolo della logica)
∨ o (simbolo della logica)
∧ e (simbolo della logica)
¬ non/negazione
(simbolo della logica)

possibile/possibilmente
(simbolo della logica)

necessario/necessariamente
(simbolo della logica)

per ogni/sempre/per tutti
(simbolo della logica)

esiste/esistono/alcuni
(simbolo della logica)if u cn rd ths, u cn lrn spdwrtg
Applicare questa tecnica in italiano può risultare più difficile. Ma si può
comunque fare con un po' di esercizio.
Ricorda, ad esempio, il modo in cui molti abbreviano le parole nello scrivere gli SMS.)
3.4. L'accuratezza non è importante
Un'altra considerazione cruciale è che gli appunti presi in classe
non devono essere scritti in modo eccessivamente accurato o ordinato.
È sufficiente che siano abbastanza leggibili
da permetterti di rileggerli poche ore (o al massimo pochi giorni) più tardi.
La ragione di ciò ti sarà chiara più avanti.
3.5. Fai domande & Commenta
Se hai delle domande o osservazioni che ti vengono in mente mentre stai prendendo appunti,
hai due possibilità: puoi contribuire alla discussione in classe
facendo la tua domanda o il tuo commento, oppure puoi riportare la domanda o il commento sui tuoi appunti.
La prima scelta è più consigliabile, ma la seconda è sovente preferibile.
Dovresti comunque riportare in ogni caso la domanda o il commento nei tuoi appunti. In tal modo
non la dimenticherai e potrai comunque riconsiderarla più tardi, in una successiva lezione o
durante lo studio o anche andando a ricevimento dal docente.
Un'altra ragione per scrivere le tue note è che così facendo queste
diventano parte degli appunti! Una tecnica utilizzabile per distinguere le domande/commenti dal
resto degli appunti consiste nel scriverle a margine e/o racchiuderle tra grosse parentesi quadre
[come queste.]
3.6. A casa ricopia i tuoi appunti
Nota che questa sezione è intitolata
"Prendi appunti in classe & Riscrivili a casa;
Il titolo non è "Prendi appunti in classe & Studiali a casa".
Ovviamente dovrai studiare i tuoi appunti a casa, ma limitarsi a
(ri-)leggerli non basta: è troppo passivo.
Uno degli scopi di questa guida è evidenziare che lo studio
deve essere attivo. È estremamente facile perdere la concentrazione
o addirittura assopirsi mentre si legge gli appunti in modo passivo:
1. Idea 1
- dettaglio 1
- dettaglio 2
- ulteriore dettaglio 2.1
- dettaglio 3
- ulteriore dettaglio 3.1
- ulteriore dettaglio 3.2
2. Idea 2
3. Idea 3
ecc.
3.7. Non prendere appunti usando il computer
Ti consiglio di non prendere gli appunti in aula usando il laptop.
Sicuramente non lo dovresti fare se non sei molto bravo nello scrivere alla tastiera
e se non hai "compilato" il tuo word-processor o il tuo editor
direttamente nei polpastrelli. (In ogni caso, scrivere alla tastiera può
risultare rumoroso e disturbare gli altri studenti!)
Inoltre, scrivere gli appunti al computer in aula contrasta con la mia raccomandazione
di riscriverli a casa.
Ovviamente, puoi editare il tuo file più tardi,
ma editare non è la stessa cosa che ricopiare, ed io ti sto proponendo di ricopiare il materiale
come metodo di studio (anche perché ciò ti forza a (ri-)leggere gli appunti).
Naturalmente, puoi copiare in un file, in versione pulita,
gli appunti presi "grezzamente" in aula. Potrebbe essere una questione di
gusto o di abitudine, ma trovo più facile afferrare i concetti
quando li scrivo a mano piuttosto che quando li digito alla tastiera.
(Parafrasando Usama Fayyad potremmo dire che:
i computer sono "ottimi per memorizzare informazioni ma non altrettanto per registrare
impressioni, idee, riflessioni, sensazioni. Per questi la carta è ancora decisamente meglio. Puoi toccarla, piegarla, intascarla, riprenderla in mano, riguardarla al volo quando ti serve"
(per una citazione in inglese vedi
Swerdlow 1999: 130).)
Bugeja, Michael J.
(2007),
"Distractions in the Wireless Classroom",
Chronicle of Higher Education
(26 gennaio): C1,C4.
3.8. Non confidare nei lucidi e nelle dispense del docente
Alcuni docenti forniscono le loro note delle lezioni e/o il materiale usato in aula,
su web o in forma di lucidi. Questo materiale può essere utile
ma non devi basarti su esso.
Se tutto ciò che fai con questo materiale è stamparlo,
forse leggerlo una volta, e riporlo, allora è materiale inutile
perché lo stai utilizzando passivamente.
Lo devi utilizzare esattamente come tratteresti
gli appunti scritti da te: riscrivilo!
Meglio ancora: usalo per riempire le lacune presenti nei tuoi appunti mentre li
riscrivi
e per controllare se hai commesso errori nel prendere appunti in aula
(Osserva che, nelle note del docente potresti trovare del materiale che non
è stato trattato a lezione oppure potresti trovare nei tuoi appunti
del materiale discusso a lezione ma che non appare nelle note del docente).
3.9. Ulteriori letture
La loro argomentazione fornisce molte buone ragioni per procedere in questo modo.
4. Studia prima gli argomenti difficili & studia in un luogo silenzioso
Willingham, Daniel T.
(2010),
"Have Technology and Multitasking Rewired How Students Learn?",
Ask the Cognitive Scientist,
American Educator
(Summer): 23–28, 42.
[PDF])
5. Leggi i testi attivamente & lentamente, prima & dopo ogni lezione
Contenuti:
5.1. Leggi il testo attivamente, non passivamente
Qui con 'testo' intendo qualsiasi cosa tu debba leggere: un libro di testo,
un copione, una poesia, un saggio, un articolo di una rivista, o anche gli appunti
della lezione.
Con una sola eccezione, non leggere mai
passivamente. Cioè, non leggere superficialmente senza riflettere su cosa stai leggendo.
5.2. Leggi lentamente.
WHILE c'è un'altra frase da leggere DO:
BEGIN (* while *)
Leggi la frase, LENTAMENTE;
IF non la hai capita THEN
BEGIN (* if *)
ri-leggi il materiale che precede la frase, LENTAMENTE;
ri-leggi la frase incomprensibile, LENTAMENTE;
IF non la hai ancora capita, THEN
chiedi a un altro studente di spiegartela;
IF non la hai ancora capita, THEN
chiedi all'assistente o all'esercitatore del corso (se c'è) di spiegartela;
IF non la hai ancora capita, THEN
chiedi al docente di spiegartela;
IF non la capisci & stai seguendo un corso avanzato (ad es. magistrale, dottorato), THEN
scrivi un paper sull'argomento (!)
END (* if *)
END; (* while *)
5.3. Evidenzia al margine il testo
Esistono alcuni ulteriori trucchi per leggere in modo attivo.
Naturalmente, una è evidenziare i passaggi importanti o interessanti.
Vi sono molti modi di farlo.
Il peggiore consiste nell'utilizzare un evidenziatore giallo
(o rosa, o di qualsiasi altro colore tu preferisca).
Il principale problema in questo metodo è che tenderai a considerare
praticamente ogni frase come importante o interessante. Conseguentemente,
ogni pagina diverrà gialla (o rosa, o altro).
Non solo questo vanifica lo scopo dell'enfatizzare il testo—perché
se tutto è enfatizzato, allora niente lo è!—ma
le pagine del testo diverranno madide, increspate e in generale poco chiare.
5.4. Aggiungi annotazioni ai margini
Dovresti sempre aggiungere annotazioni a margine delle pagine (se c'è spazio e se il libro è tuo).
Io preferisco aggiungere dei riferimenti a margine delle pagine.
Per esempio, se un passaggio a pagina 20 in qualche modo mi ricorda
un passaggio a pagina 10, allora scrivo "vedi p.10" al margine di p.20 e
"vedi p.20" al margine della 10.
Oppure aggiungo delle parole chiave al margine di un passaggio che in qualche
modo mi ricorda un'idea basilare.
5.5. Raccogli le annotazioni in un notes
Come abbiamo visto, evidenziare il testo ha lo svantaggio di portare ad evidenziare tutto,
mentre apporre annotazioni a margine ha il difetto che spesso non c'è
abbastanza spazio se non per scrivere commenti brevi e concisi.
La tecnica migliore per leggere attivamente è raccogliere le
annotazioni in un block-notes. In aggiunta (o invece) di evidenziare
un passaggio importante, ricopialo —verbatim— nel tuo notes.
Accertati di iniziare il notes con una
citazione bibliografica completa del testo e
scrivi i numeri di pagina del passaggio che stai ricopiando.
Dopodiché scrivi —per esteso e in dettaglio—i tuoi commenti
al passaggio.
(Usualmente io uso una penna per il testo e una matita per i commenti).
5.6. Compi una prima lettura velocemente e passivamente.
Prima ho detto che esiste una eccezione alla
prescrizione di leggere lentamente e attivamente.
Se il testo è letterario (una storia, una novella, un copione, un poema, ecc.),
è spesso meglio effettuare una prima lettura di tutto il testo, senza pause,
come se lo leggessi per diletto. Così ne potrai cogliere gli aspetti generali ed
apprezzare integralmente il suo carattere.
(Se esiste una registrazione del testo, potresti trovar utile
ascoltarla mentre leggi; Ho trovato questa tecnica utile specialmente per studiare Shakespeare).
Successivamente, userai le tecniche della lettura lenta ed attiva per la tua
seconda (o terza, quarta,...) lettura, quando studierai il testo.
5.7. Leggi prima e dopo la lezione
Idealmente dovresti leggere un testo almeno due volte. Leggilo (anche velocemente)
prima della lezione in cui verrà discusso/spiegato, così da
acquisire familiarità con l'argomento.
Poi (ri-)leggilo dopo la lezione usando il metodo lento e attivo
6. Fai gli esercizi assegnati "per casa"
7. Studia per l'esame
Contenuti:
7.1. Gestisci il tuo tempo
Prima ho discusso la gestione del tempo. Quando devi
prepararti per un esame la gestione del tempo diventa ancora più cruciale.
Inizia a studiare almeno una settimana prima dell'esame (specie se si tratta di
un esonero di medio termine). Dedica almeno un'ora
ogni sera (o giorno) per studiare come ti descrivo qui di seguito.
Cerca di dedicare allo studio l'intero giorno (e/o notte) prima dell'esame.
Se hai due esami nello stesso giorno dovrai ripartire i tempi.
GIORNO PARTE DEL GIORNO COSA FARE
Giorno 1 mattino studia per l'esame #1
pomeriggio studia per l'esame #2
sera studia per l'esame #3
Giorno 2 mattino studia per l'esame #1
pomeriggio studia per l'esame #2 o #3 (o entrambi)
sera studia per l'esame #1
Giorno 3 mattino studia per l'esame #1
pomeriggio dai l'esame #1
sera studia per l'esame #2
Giorno 4 mattino studia per l'esame #3
pomeriggio studia per l'esame #2
sera studia per l'esame #3
Giorno 5 mattino studia per l'esame #2
pomeriggio dai l'esame #2
sera studia per l'esame #3
Giorno 6 dai l'esame #3
7.2. Come non studiare
Credici o meno,
ri-leggere il tuo libro ha "effetto limitato o nullo" quando stai studiando per un test. (Callender &a
McDaniel 2009).
7.3. Stila un indice
Usa i tuoi appunti ricopiati, assieme al testo evidenziato e al tuo notes,
per stilare un indice del materiale da studiare.
Cerca di elencare il più possibile in solo 1 o 2 fogli di carta.
Quindi svolgi in tuo studio a partire da questi. (Puoi anche
combinare questi indice con i "promemoria".)
7.4. Scrivi componimenti & svolgi esercizi
Per le materie che prevedono test scritti o relazioni, puoi cercare di
intuire quali saranno i temi che il docente potrebbe proporre in un esame.
Oppure puoi ottenere le copie dei test di precedenti esami. Quindi
scrivi e svolgi gli esercizi.
Anche se le domande che trovi o inventi non saranno proprio quelle che
troverai nell'esame, scoprirai che molto del materiale che hai scritto
per rispondere a tali domande, durante la
preparazione dell'esame, sarà anche parte del vero esame.
Sarai quindi avvantaggiato durante l'esame, quando dovrai rispondere a
domande poste su argomenti che hai già maneggiato. Non dovrai creare da zero
le risposte alle domande ma potrai semplicemente riciclare
le idee principali che hai già elaborato durante lo studio.
7.5. Scrivi dei "promemoria"
Per ogni materia puoi sempre scrivere dei brevi promemoria.
Suggerisco di utilizzare normali fogli di carta. Dividi ogni pagina
a metà, verticalmente.
Sulla sinistra scrivi una "domanda" che richiede una "risposta",
per es. il nome di un teorema, un termine da definire,
l'enunciato di un teorema, ecc. Sulla destra scrivi la risposta,
per es., l'enunciato del teorema, la definizione del termine,
la dimostrazione del teorema, ecc. (Questo potrebbe anche fungere da
indice per il tuo studio.)
7.6. Smetti di studiare quando ti senti sicuro
Come capisci se/quando hai studiato abbastanza?
Non è quando sei stanco di studiare!
E non è quando hai processato tutto il materiale una sola volta!
Dovrai fermarti solo quando ti sentirai abbastanza fiducioso di essere pronto,
qualsiasi sia l'esame che ti troverai davanti—quando
sarai impaziente di sapere come sarà l'esame e se sei stato bravo nel
prepararti.
8. Sostieni l'esame
Prima di tutto leggi interamente il testo dell'esame.
9. Ricerca & scrivi relazioni.
Contenuti:
9.1. Scegli accuratamente il soggetto
Scegli con saggezza il soggetto. Evita i casi estremi di argomenti così
ampi e ben conosciuti da presentare troppe fonti di informazioni
e argomenti così specifici o poco conosciuti da avere scarsità informazioni.
Se hai difficoltà nello scegliere un argomento, chiedi al docente.
9.2. Ricerca
Una volta scelto l'argomento e trovate le opportune fonti di
materiale, leggile lentamente e attivamente
mantieni un notes con gli appunti.
Non ripeterò qui i suggerimenti dati in precedenza, con una eccezione:
Sii certo di registrare accuratamente le fonti e i numeri delle pagine di ogni passaggio
che riporti nella tua composizione, in tal modo potrai riportarle nella versione finale della tua relazione.
9.3. Stila una traccia
Questa fase potrebbe richiedere più iterazioni.
Dovresti scrivere un indice/traccia e riorganizzare le tue annotazioni e appunti
in categorie che corrispondano alle sezioni principali del tuo indice.
Ma quale di queste cose devi fare per prima? Non importa.
Puoi avere un indice chiaro in mente, in tal caso riordinare le note sarà
relativamente facile (anche se potresti scoprire che alcune note non si incastrano bene nella tua traccia/indice, oppure ti suggeriscono di aggiungere una sezione che
all'inizio non avevi considerato). Oppure potresti voler/dover prima riordinare
gli appunti e poi creare un indice basandosi sulle categorie che hai
determinato organizzando gli appunti.
intro argomento1 argomento2 argomento3 conclusione
9.4. Scrivi, basandoti sulla traccia
(più o meno letteralmente: "Come posso dire cosa penso se non vedo cosa dico?")
9.5. Edita
Dopo aver scritto la prima versione, ri-leggi ciò che hai scritto, usando il
metodo della lettura lenta e attiva, e rivedi
(o "edita") il tutto. Quindi chiedi ad un amico di leggere e di darti
feedback. Rivedi di nuovo tutta la composizione e
prepara la versione finale.
9.6. Gestisci il tuo tempo
Slatalla, Michelle (2007),
"The Big Dilly-Dally",
New York Times Education Life
(7 gennaio): 14-15.
9.7. Alcuni articoli interessanti sullo scrivere:
(in italiano, qualcosa di simile a:
Trova un argomento che ti interessa. Non divagare. Scrivi in modo semplice. Abbi il fegato di scorciare. Sii te stesso. Dì ciò che intendi dire. Abbi pietà del lettore.)
10. Ma devo proprio fare tutto ciò?
11. Esistono altri siti web che forniscono suggerimenti su come studiare?
Sì, ecco una lista di quelli che mi sembrano migliori. Molti di essi contengono ulteriori riferimenti:
Bibliografia
"An Assortment of Learning Styles",
Chronicle of Higher Education
(8 gennaio 2010): A8; publicato online il 15 dicembre 2009.
Mayer, Richard E. (2009),
"Editorial: Advances in Applying
the Science of Learning and Instruction to Education",
Psychological Science in the Public Interest 9(3): i–ii.
Text copyright © 1999–2011 by William J. Rapaport
Cartoon links and screen-captures appear here for your enjoyment and are not meant to
infringe on any copyrights held by the creators.
For more information
on any cartoon, click on it, or contact me.
(rapaport@buffalo.edu)
http://www.cse.buffalo.edu/~rapaport/HOWTOSTUDY/comestudiare.html-20110919